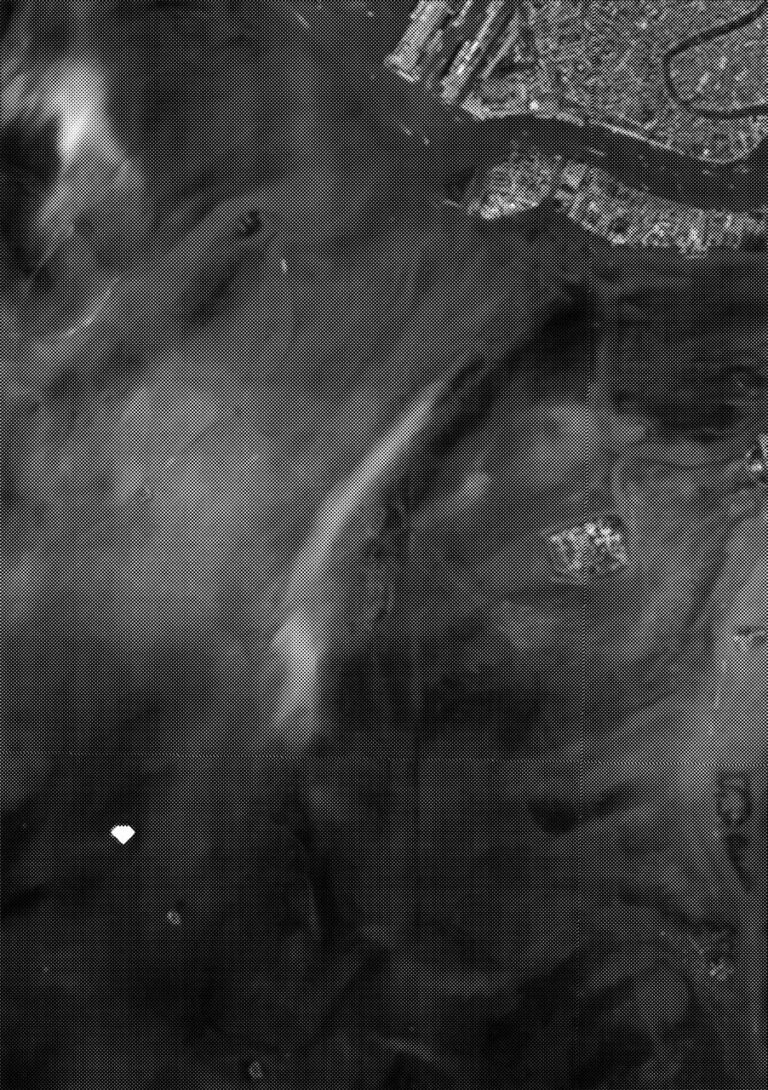Isolario

Ricerca IUAV a inviti “Isolario Venezia Sylva” per l’Isola di San Marco in Boccalama
A Kind of Magic
“Bodkin si era smarrito nei suoi sogni a occhi aperti, vagando senza meta per i canali in cerca del mondo sommerso della sua infanzia.”
(J.G. Ballard 2005, p. 96)
San Marco in Boccalama non c’è, dell’isola è rimasto solo un fatto onirico. La cogente realità che ne racconta l’esistenza è oggi un ossimoro: un monolite metallico inanimato, carcassa marina di un’epoca ormai post-industriale, ritratto odierno dell’isola della quale nulla è rimasto sopra l’acqua se non il recinto stesso stabilito per proteggerne i resti, le vestigia di quel “mondo sommerso”. Boccalama è memoria di un tempo lontano, in cui la Laguna era medium liquido, infrastruttura per la sopravvivenza umana in un ambiente ostile e al contempo fluido amniotico in cui Venezia, e la germinazione delle sue isole, ha potuto preservarsi dagli eventi della storia. Venezia è città per certi versi mai nata, mai violentata, né corrotta né invecchiata, eternamente separata, immersa nel proprio “attimo”, ambiente passato-presente-futuro riservato esclusivamente a sé stessa. Ma Boccalama è anche la previsione, predizione o monito, di un tempo futuro possibile in cui l’acqua si impadronirà di nuovo di tutto lo spazio che ha concesso all’uomo per insediarsi, riconducendo la sua opera alla condizione di fondale, sottostruttura artificiale per nuove esistenze naturali. La cortina di palancole, riduzione tecnica “per man dell’uomo” delle barene che proteggono l’intera laguna, si manifesta ben al di là delle proprie intenzioni originarie. Il muro metallico può essere ritenuto oggi una specie di installazione “involontaria” a protezione di un «residuo» secondo le categorie di Gilles Clément (Clément, 2014). Ciò che resta della questione è, dunque, questo temenos performativo e al tempo stesso programmatico, sorta di fanum posto, esattamente come nelle antiche tradizioni, al di fuori della città, sul confine tra il “normato” e “non-normato”; anzi, già incardinato all’interno di quest’ultimo come avamposto umano nei territori dell’in-umano. Fuori del recinto l’acqua è crespa, in movimento, soggetta al tempo e alle attività umane mentre all’interno, come una cripta medievale, l’acqua al contrario è ferma, immobile in attesa di un evento che la faccia riunire alla gemella da cui è stata separata. Superficie in attesa ed inattesa, corpo estraneo e residuale rispetto alla Laguna. Come in un sacello, mitraneo a cielo aperto, le vestigia sommerse tentano di vincere gli effetti del tempo, sia cronologico che meteorologico, verso un indefinibile traiettoria di cui nessuno può scorgere il punto di arrivo. La strategia si complica, Boccalama va raccontata, ma nei termini del suo essere inesistente. Se riteniamo, e ne siamo convinti, che l’architettura sia cosa inutile (Dardi 1987, p. 23), sovrastruttura artistica del tutto umana destinata semplicemente a vincere la morte del contenitore biologico dell’”essere”, non possiamo che inoltrarci nell’onirico, assumendo il magico come grammatica di ri-scrittura per la possibile consacrazione di un nuovo tempio. Il disegno si svincola dall’ossessione della perfezione come tautologia dell’edificare, perseguendo un immaginario veneziano già raccontato da William Turner in cui individuare un ulteriore climax narrativo che non è quello dell’isola bensì quello che la superficie lagunare instaura con il proprio paesaggio. L’approssimazione delle figure, come nelle pennellate dell’ultimo Tiziano, sfuma ogni sagoma determinando per l’osservatore una variabile percettiva ulteriore e in grado di conversare direttamente con il nous. Il perimetro ferreo delle palancole viene così dissolto da un bosco di briccole la cui geometria d’impianto, a densità variabile, confuta la chiarezza costruttiva dell’oggetto industriale retrostante. La dissoluzione, attraverso la sovversione della funzione di dispositivi archetipici riconoscibili, è azione progettuale del ricollocare questo “fuori registro” all’interno delle rotte lagunari. Nuovi approdi possibili, le briccole potranno accogliere i convenzionali rituali della tribù veneziana di abbraccio alla laguna, permutando nel tempo ciclico di Venezia pratiche di appropriazione e di conoscenza altrimenti in oblio. Le palancole, arredate con piani di calpestio, si prestano a fornire un eventuale e inedito percorso di ronda, punto di osservazione “opposto”: dal fuori verso il dentro. Il “bosco magico”, junghiana “immagine primordiale”, trascende il mito e la favola in manifestazione del necessario desiderio umano di oltrepassare le distanze delle contingenze di una vita fisica altrimenti costretta all’interno del perimetro ostile della propria determinatezza, secondo metrica e nuovo punto d’osservazione di quel leopardiano “ultimo orizzonte”.
“One shaft of light that shows the way, No mortal man can win this day, It’s a kind of magic.” (Queen 1986)
Architettura
Michelangelo Pivetta
Giacomo Razzolini
Vanni Renzini
Anna Chiara Zei
Anno
2021